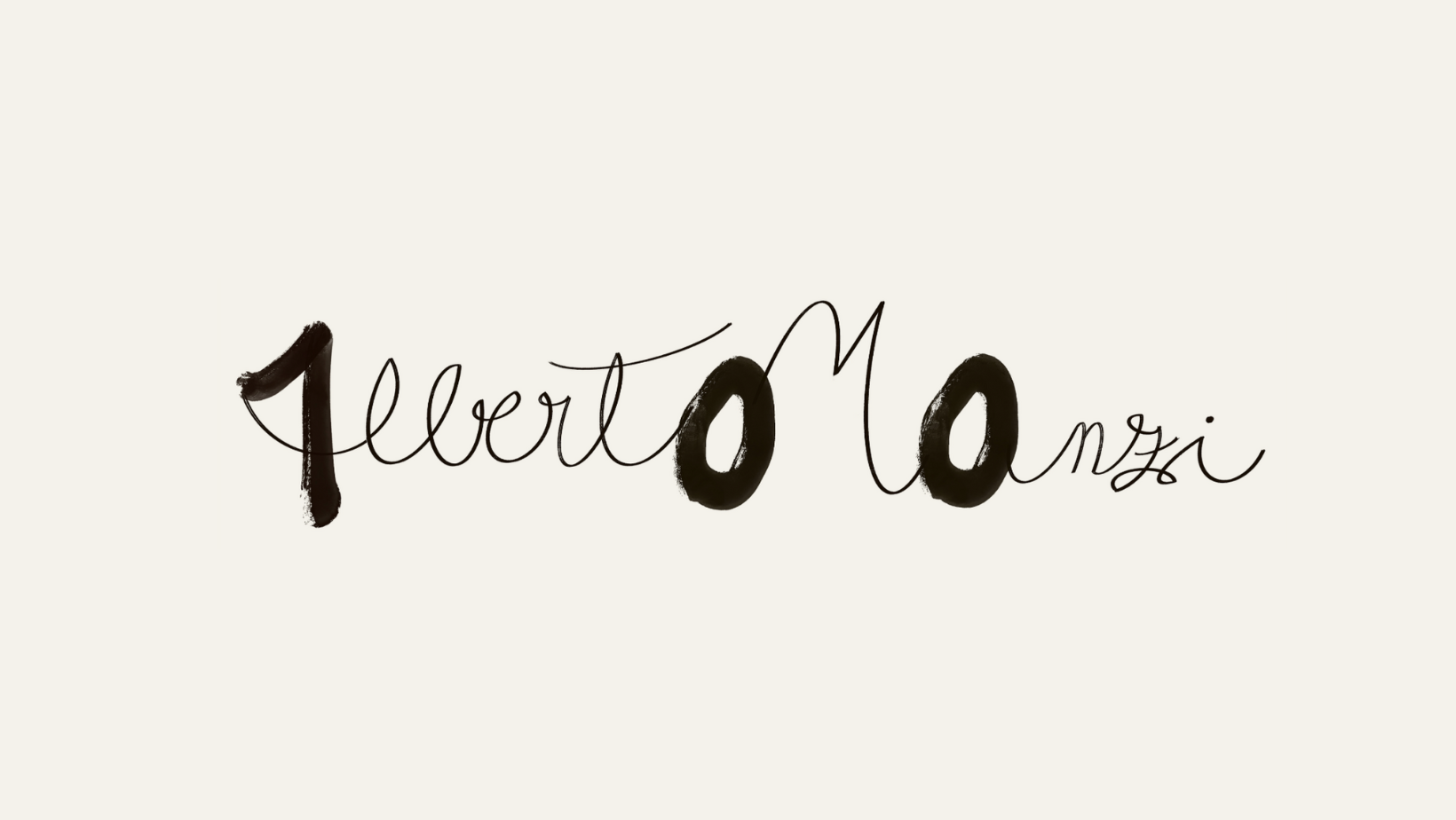Alberto Manzi: il maestro molto noto che pochi conoscono.
Paolo Ferrero
Alberto Manzi è noto per la trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi che andò in onda tra il 1960 e il 1968. Questo Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti – come recitava la didascalia – nacque dalla collaborazione tra RAI e Ministero della Pubblica Istruzione, e determinò un vero e proprio fenomeno sociale. In primo luogo per la dimensione quantitativa: martedi, giovedi e venerdi, alle 18, milioni di persone erano sintonizzate su RAI 1 per vedere il “maestro d’Italia”, e oltre 1 milione di persone conseguirono la licenza elementare grazie a questo programma. In secondo luogo, per una ragione qualitativa: gruppi organizzati e gruppi spontanei di ascolto diffusi in tutta la penisola, bambini e nonni uniti nello stesso sforzo collettivo. Non è mai troppo tardi infatti non veniva solo seguito dagli adulti analfabeti ma anche da moltissimi bambini, come una sorta di interessante doposcuola. Si trattò di un progetto complesso di educazione a distanza, che in parallelo alla trasmissione televisiva aveva oltre 2.000 Pat (posti di ascolto televisivo) sparsi in tutta Italia, dove un insegnante seguiva insieme al gruppo di allievi adulti la trasmissione, e poi svolgeva con loro l’attività didattica per consolidare gli apprendimenti. Chi di loro voleva poteva poi affrontare l’esame per la licenza elementare. Stiamo parlando di un’Italia in cui l’analfabetismo adulto riguardava poco meno del 10% della popolazione, senza considerare i semianalfabeti.
Fu un successo strepitoso dovuto alla pedagogia messa in campo da Alberto Manzi che, non a caso, quando fece il provino nella selezione per la trasmissione, gettò via il copione e presentò il modo in cui lui avrebbe fatto la lezione. Chiese un blocco di grandi fogli bianchi e cominciò – come normalmente poi avvenne in trasmissione – con un disegno da cui poi si dipanava la lezione. Accanto a questo, una lavagna luminosa, che per l’epoca rappresentava il non plus ultra dell’innovazione tecnologica. Porre al centro l’attenzione degli ascoltatori/alunni, attrarre l’interesse e da qui sviluppare l’insegnamento, fu il nucleo della didattica di Alberto Manzi: il contrario del nozionismo autoritario che aveva caratterizzato la scuola fascista e che continuava a essere assai presente nella scuola della Repubblica. Per dirlo con le parole del maestro: “Non insegnavo a leggere e scrivere, invogliavo la gente a leggere e a scrivere”, e intanto “continuavo a percepire il mio stipendio di maestro elementare. Dalla Rai ricevevo un ‘rimborso camicia’ perché il gessetto nero che usavo per fare i disegni era molto grasso, si attaccava ai polsini della camicia e li rovinava ”.
Manzi univa alla radicalità didattica una grande capacità comunicativa e un uso intelligente del mezzo televisivo, invitando ospiti – da Bartali ad Aldo Fabrizi – al fine di contribuire ad aumentare l’interesse degli ascoltatori per la trasmissione.
Questo intreccio geniale e innovativo portò Non è mai troppo tardi a essere copiata da molte televisioni estere – fu riprodotta in ben 72 Paesi – a ricevere nel 1960 un riconoscimento dall’Onu e a essere premiata nel 1965 dall’Unesco come uno dei programmi più significativi a livello mondiale nella lotta contro l’analfabetismo.
Non è mai troppo tardi fu quindi un programma che fece storia, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e Manzi ne fu protagonista indiscusso. Per completezza di informazione, va ricordato che, in un contesto tutto diverso, nel 1992 la Rai ripropose Manzi ne L’italiano per gli extracomunitari, 60 puntate televisive, in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana agli immigrati.
Alberto Manzi oltre la TV
Alberto Manzi però non è stato solo questo: il Nostro, pur essendo molto noto ed apprezzato per gli effetti positivi prodotti dalla trasmissione che lo ha caratterizzato, è infatti pressoché sconosciuto per tutto ciò che stava dietro quella sua semplicità educativa tanto apprezzata: le sue idee, i suoi lavori, le sue scelte, il suo impianto pedagogico assolutamente innovativo sono del tutto sconosciuti al grande pubblico. Qui di seguito cercherò di portare alcuni elementi di conoscenza di “questo” Alberto Manzi, che merita di essere messo in compagnia di Danilo Dolci, Mario Lodi, Loris Malaguzzi, don Lorenzo Milani, Gianni Rodari. Per chi volesse approfondire la conoscenza dell’opera di Manzi, il suo archivio, donato dalla famiglia all’Università di Bologna è conservato nel Centro Alberto Manzi (www.centroalbertomanzi.it), presso la Regione Emilia-Romagna.
Alberto Manzi, nato a Roma nel 1921 in una famiglia antifascista, si diplomò nel 1943 e fu costretto a nascondersi per evitare la fucilazione, non essendosi presentato alla chiamata alle armi della repubblica di Salò. Dopo la liberazione di Roma da parte dell’esercito americano, si arruolò in un battaglione italiano aggregato agli alleati. Nel 1946 e ’47 venne mandato a insegnare in una classe di 94 ragazzi – dai 9 ai 17 anni – condannati per reati gravi, omicidi, rapina a mano armata e reclusi nel carcere minorile “Aristide Gabelli” di Roma. Accettando appena ventiduenne questo posto di lavoro che era stato precedentemente rifiutato da 4 insegnanti, ebbe poi modo di commentare: “È stata l’esperienza che mi ha costretto a progettare un modo diverso di fare scuola, perché fra questi ragazzi c’erano sia gli analfabeti, sia alcuni che avevano frequentato il primo e il secondo anno di liceo”. Con loro realizzò un giornalino, “La Tradotta” – il primo giornalino fatto in un carcere italiano – e riuscì a portare i ragazzi a fare un’esperienza di campeggio in montagna. Di loro, ci dice orgoglioso Manzi, che una volta usciti dal carcere, solo due vi rientrarono.
In quegli anni si laureò in Biologia e poi in Pedagogia con Luigi Volpicelli all’Università di Roma. E Nel 1948 ottenne il Premio Collodi per Grogh, storia di un castoro, romanzo per ragazzi inedito, pubblicato dalla Bompiani nel 1950 (con riduzione radiofonica della Rai nel 1953 e poi tradotto in 28 lingue). Gli venne proposto di fare l’assistente all’Università di Roma ma l’esperienza durò solo un anno; Manzi ritenne infatti che la vera sperimentazione didattica si facesse sul campo, e così nel 1950 cominciò a fare l’insegnante nella scuola elementare “Fratelli Bandiera” di Roma, dove rimase fino alla pensione.
Alberto Manzi pedagogo e scrittore
Proprio nella sua qualità di insegnante, fu protagonista di una contestazione – dura ma ironica, com’era nel suo carattere – delle schede di valutazione imposte dagli ordinamenti scolastici nel 1977. Alberto Manzi fece un atto di “obiezione di coscienza” e si rifiutò di compilare le schede per i suoi alunni. Manzi sostenne, pensando soprattutto ai casi più difficili tra i suoi alunni: “non posso bollare un ragazzo con un giudizio, perché il ragazzo cambia, è in movimento; se il prossimo anno uno legge il giudizio che ho dato quest’anno, l’abbiamo bollato per i prossimi anni”.
Dopo ripetuti richiami delle autorità scolastiche, Manzi reagì apponendo sulla scheda di ogni bambino un timbro che riportava la dicitura: “Fa quel che può, quel che non può non fa”. In conseguenza di questa scelta, nel 1981, il provveditore agli studi di Roma lo condannò alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per due mesi.
Da questo ultimo episodio si evince chiaramente il tratto pedagogico del maestro Manzi, fondato sulla messa al centro dei soggetti a cui l’insegnamento è rivolto, e sul carattere dinamico dell’insegnamento, centrato sullo sviluppo della personalità e sull’autocostruzione della soggettività individuale e sociale.
“Quando devo fare una cosa, mi metto nei panni degli altri. Ogni altro sono io, capite? Ogni altro sono io”. In questa frase si coglie fino in fondo l’umanesimo di Manzi e la sua concezione dell’individuo come essere sociale. Non credo sia un caso se nella prima trasmissione di Non è mai troppo tardi la prima parola che Manzi scrisse è “Io” e la seconda è “Noi”. Su questa dialettica si fonda l’idea della costruzione di sé, basata sulla capacità di relazione con l’Altro.
Questa pedagogia emerge chiaramente nei libri di Manzi: centoventi (avete letto bene, 120) testi pubblicati, la maggior parte tradotti in decine di altre lingue e da cui sono stati tratti anche sceneggiati televisivi. Il più famoso è certamente Orzowei, libro pubblicato nel 1955, da cui fu tratta negli anni ’70 la serie televisiva omonima – Orzowei il figlio della savana – che venne trasmessa nella “tv dei ragazzi”. Impossibile dar conto di questa sterminata produzione libresca che spazia dai libri per ragazzi alle opere di pedagogia al romanzo e al dramma di denuncia delle ingiustizie sociali.
Questa attività di pubblicista fu strettamente intrecciata con la sua maturazione politica, e in particolare con la sua frequentazione dell’America Latina.
In America Latina, dalla parte degli sfruttati
L’esperienza sudamericana è quella meno conosciuta, ma ha un ruolo assai rilevante nella maturazione politica ed esistenziale del Nostro. E’ lui stesso che ne riconosce il valore: “Ero andato in Sud America per studiare le formiche, ma vi ho trovato cose più importanti”. Come ha puntualmente sottolineato sua figlia, Giulia Manzi, “l’Alberto Manzi che andava a insegnare agli indios a leggere e a scrivere, che denunciava la violenza di un potere politico sulla povera gente, che rischiava la sua vita in nome dell’educazione e della dignità umana (…) quell’Alberto Manzi lo conoscono in pochi. Sebbene non parlasse spesso delle sue peripezie sudamericane, esse vivono in forma romanzata nei suoi libri”.
Esprime bene questo percorso Roberto Farnè, che su “La rivista il Mulino” scrive: “Nel 1954 Manzi va per la prima volta in Sudamerica con una borsa di studio come biologo per studiare un tipo di formiche in Brasile. Ben presto si accorge della condizione di sfruttamento dei contadini che, analfabeti, sono privati dei diritti politici: non possono votare o iscriversi al sindacato, e chi insegna loro a leggere e scrivere viene spesso preso e picchiato. Manzi è colpito da questa realtà e comincia così, anno dopo anno, per circa vent’anni, a trascorrere parte delle sue vacanze in Sud America, avendo come punto di riferimento una comunità di Salesiani, tra Perù ed Ecuador, dove fa l’educatore, alfabetizzando gruppi di indios. Appartengono a queste esperienze i romanzi di ambientazione sudamericana: La luna nelle baracche (1974), El loco (1979), E venne il sabato (2005, postumo); una trilogia in cui i temi esistenziali e sociali di quella umanità trovano la loro forma espressiva e comunicativa. Sono gli anni in cui Paulo Freire costruisce la sua ‘pedagogia degli oppressi’ e si sviluppa la ‘teologia della liberazione’. Racconta Alberto Manzi: “Poi cominciarono ad accusarci di essere guevaristi, oppure papisti o un qualunque accidente che finiva in “isti”, per cui iniziarono ad arrestare dei gruppetti e io non me la sentivo più di rischiare la vita di questi ragazzi. In Perù e Bolivia, dove la situazione politica si era fatta pesante, non era possibile tornare. Alcuni Stati non mi davano più il visto: non ero una persona gradita. Durante quei viaggi, per esempio, ho conosciuto i sacerdoti sudamericani che aderivano alla teologia della liberazione. Molte volte ne abbiamo discusso a Lima, a Quito: si voleva capire se la Chiesa doveva servire l’uomo o il potere”.
L’alfabetizzazione coscientizzatrice proposta da Freire, secondo cui “la liberazione autentica, che è umanizzazione in processo […] Non è una parola in più, vuota, creatrice di miti. È una prassi, che comporta azione e riflessione degli uomini sul mondo, per trasformarlo” diventa parte costitutiva del pensiero di Manzi. L’analisi critica della propria condizione come primo e indispensabile passo che crea il terreno per consentire ai popoli sottomessi di sollevare la testa viene fatto proprio fino in fondo da Manzi, e diventa uno dei nodi fondamentali dei suoi romanzi. La conoscenza della parola e della cultura come strumento per comprendere la propria condizione e per “guardare il sole, sempre, sempre”, come ne La luna nelle baracche auspica Madalena per suo figlio. Questa è la pedagogia della liberazione che caratterizza Manzi, indissolubile dalla sua esperienza latinoamericana e che si intreccia con la teologia della liberazione: “Chiamalo come ti pare. In fondo spesso la chiesa stessa per anni e anni ha assecondato questo paternalismo. Ora noi preti non accettiamo più, non possiamo accettare più. E la guerra è scoppiata: le vittime sono tante e ogni giorno aumentano. C’è gente che viene deportata, torturata e spesso uccisa. E nessuno può dir niente. Chi denuncia questi fatti viene chiamato comunista, rosso, bolscevico: così a te prete che denunci queste infamie, ti chiudono la bocca e ti mettono in galera come “comunista”. […] Volevo andare nei villaggi a far scuola, e mi hanno picchiato a sangue; sono stato ricoverato per alcuni mesi in ospedale. Sono ritornato a far scuola, e nuovamente mi hanno bastonato. Ma la mia tristezza non è questo; una bastonata in più o in meno non ti fa perdere la fede in te stesso; è la gente che non spera più”.
La perdita della fiducia in se stesso è certamente uno dei temi centrali su cui Manzi arriva a riflettere nella fase della sua maturità e nel 1983 scrive: “Io devo cantare la rabbia del silenzio. Devo gridare il dolore della parola. Devo farlo ora, se voglio ancora sentirmi uomo, essere uomo”. Siamo di fronte alla necessità di mettere in discussione lo sfruttamento come elemento costitutivo della propria identità e umanità.
In una lettera del 9 gennaio 1985, Manzi stesso afferma: “Se ho preso posizione… sì, innanzi tutto come uomo, che rispetta altri uomini, che li vuole rispettati e che fa quel che gli è possibile per dar loro una mano. Come scrittore, facendo conoscere alcuni aspetti del problema ‘sud America’ ” (Centro Alberto Manzi 2014, p. 4).
E’ un Manzi impegnato che paga pesantemente le sue scelte. Come ci racconta Andrea Mulas, in uno splendido saggio su Alberto Manzi e l’America Latina apparso sulla rivista “Cosmopolis”:
“L’Alberto Manzi sudamericano è un missionario laico che ha dedicato la sua esistenza al prossimo, non senza pagare in prima persona per le sue scelte. Il maestro, infatti, viene arrestato per difendere una ragazza che veniva malmenata dagli uomini della compagnia che controllava l’estrazione dell’argento. Solo recentemente Giulia Manzi ha scritto dell’esperienza di suo padre nelle carceri boliviane: ‘volevano fargli confessare di essere lì per motivi politici, quindi finirono per torturarlo: la polizia gli spegneva le sigarette sulle gambe e gli strappavano le unghie. Restò in carcere un mese’. Riacquista la libertà grazie ai suoi amici di tante avventure don Giulio e Hernan, uno dei capi della guerriglia del movimento di liberazione nazionale boliviano. Quest’ultimo, a sua volta, viene fatto evadere dal carcere nel 1984 a seguito di un piano di fuga messo in atto da Manzi e don Giulio. Rientrato in Italia malconcio da questa rischiosa avventura, il maestro non farà ritorno in Amazzonia”.
E oggi?
Credo che l’ultima esperienza citata possa compendiare efficacemente la vita di questo personaggio eccezionale che è stato Alberto Manzi e confidando di avervi acceso qualche interesse e di avervi spinto ad andare a leggere qualcuno dei suoi magnifici libri.
Per parte mia, voglio chiudere questo articolo con una riflessione aperta. Alberto Manzi ha giustamente sottolineato come la conoscenza sia fondamentale per ogni processo di emancipazione. L’esperienza latinoamericana lo ha portato a valorizzare non solo la conoscenza in sé ma anche la demistificazione dei rapporti di sfruttamento, la presa di coscienza di “cosa sta dietro” l’apparenza delle cose. E’ un percorso che conosciamo bene e che coincide con l’essenza del marxismo: rendere chiara la realtà così come essa è, e non come viene raffigurata dall’ideologia dominante.
Questo percorso di comprensione ed emancipazione, è oggi sfidato a un livello molto più alto di quello che Manzi si è trovato ad affrontare nel secondo dopoguerra: la manipolazione delle informazioni ha raggiunto un livello inimmaginabile perché viene posta in essere da parte dei media mainstream come dei complottisti, in un gioco di specchi in cui ognuno rivendica la verità della sua tesi ma parimenti manipola le informazioni e la realtà. Le sciocchezze sulle scie chimiche vanno di pari passo alla stampa che pubblica la foto di un massacro fatto da un missile ucraino presentandolo invece come russo. Ovviamente, in questa contrapposizione che si nutre di fact-checking sulle informazioni dell’altro ma non sulle proprie, tutto diventa confuso e incerto. Tutti si riempiono la bocca di scienza, ma in realtà il metodo scientifico viene calpestato e stravolto.
Mi permetto allora di dire che, per cercare di essere fedeli alla lezione di Alberto Manzi, dobbiamo evitare ogni “arruolamento” ad uno dei due schieramenti, a quello mainstream o a quello complottista. Anzi, il vero lavoro di conoscenza da fare è quello di produrre un’analisi critica, che sia in grado di demistificare la realtà sociale come le proprie acquisizioni e realizzazioni. Quella strada indicata da Marx, di produrre “una critica critica” e nello stesso tempo di demistificare l’ideologia come falsa coscienza. Non è mai troppo tardi…