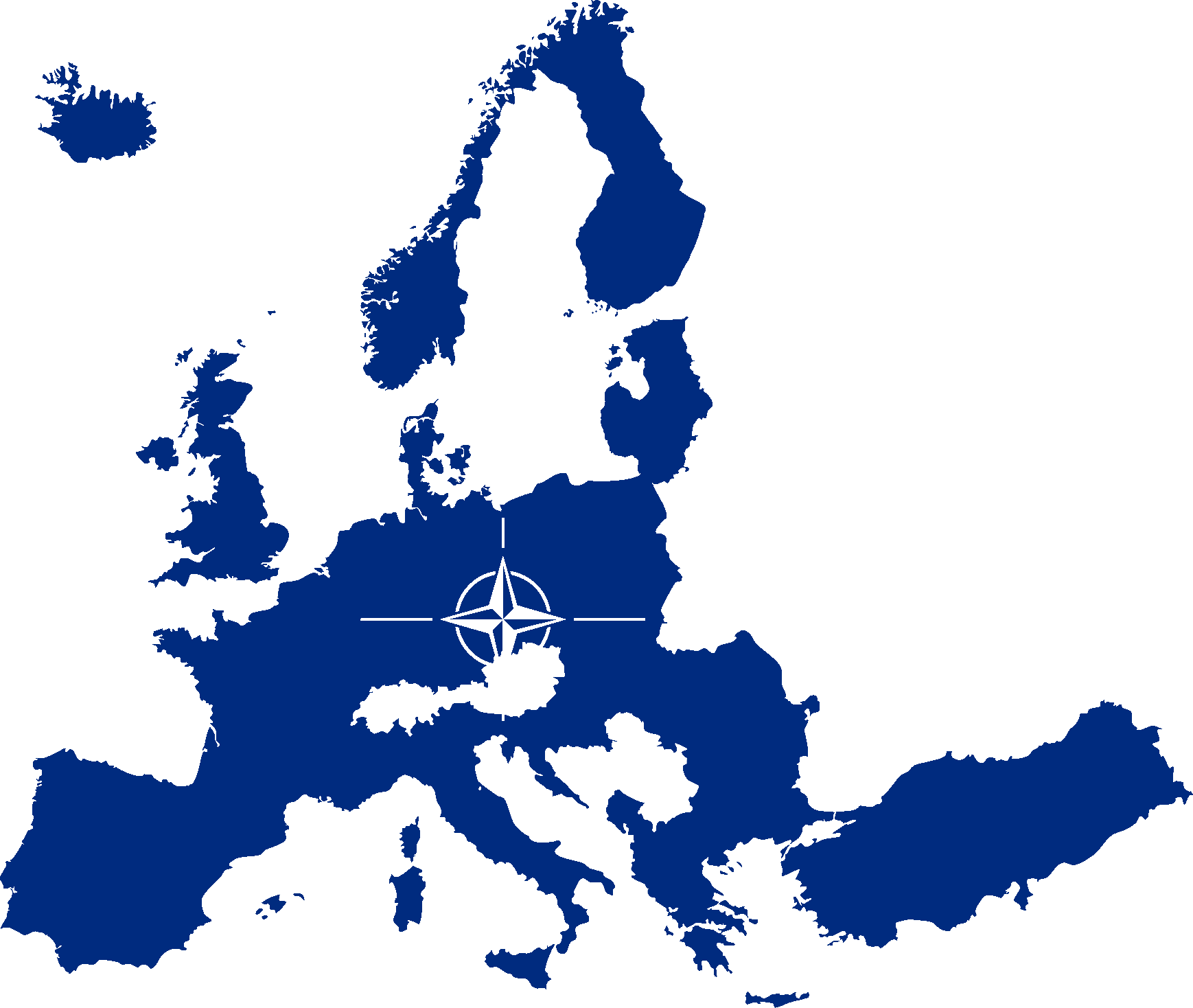L’Europa unita: un progetto atlantista e neoliberale di successo
Alessandro Somma*
Al principio fu il Piano Marshall
L’inizio del processo di unificazione europea viene convenzionalmente fatto coincidere con una dichiarazione pronunciata il 9 maggio 1950 dall’allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman, nella quale si auspicava la messa in comune della produzione di carbone e acciaio come espediente attraverso cui assicurare la pace. Sembra però più appropriato identificare come atto fondativo dell’Europa unita un’altra iniziativa concepita non tanto per prevenire un conflitto bellico, quanto per serrare le fila in vista della confrontazione tra Stati Uniti e Unione sovietica: il varo dello European recovery program, o Piano Marshall, dal nome del Segretario di Stato che ne illustrò le linee di fondo in un noto discorso tenuto il 5 giugno 1947 all’Università di Harvard.
Il Piano prevedeva l’assistenza finanziaria per consentire la ripresa dell’economia europea e nasceva da una preoccupazione di fondo: che il capitalismo non fosse capace di promuovere crescita e benessere e che questa mancanza inducesse le popolazioni impoverite a rivolgere lo sguardo verso il socialismo. Il tutto mentre le forze politiche che si richiamavano al comunismo riscuotevano successi elettorali importanti e guadagnavano ascolto crescente nel movimento sindacale.
Di qui l’urgenza di serrare le fila dell’occidente capitalista, obiettivo per il quale gli Stati Uniti e i Paesi beneficiari del Piano Marshall diedero vita all’Organizzazione europea di cooperazione economica (European organization for economic cooperation). Il trattato istitutivo si occupava del coordinamento delle politiche economiche nazionali al fine favorire la stabilità delle loro monete e l’equilibrio di bilancio. Individuava poi i termini di un incremento dei vincoli comunitari: si occupava della costruzione di un mercato comune al cui interno realizzare la libera circolazione delle merci e dei lavoratori, e persino di un embrione di unione monetaria.
Per assicurarsi la realizzazione delle sue finalità costitutive, l’Organizzazione europea di cooperazione economica venne affiancata dall’Amministrazione di cooperazione economica (Economic cooperation administration), un’agenzia governativa statunitense cui venne affidata la supervisione del Piano Marshall. Il tutto ricorrendo a condizionalità in quanto l’assistenza finanziaria era vincolata alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel trattato istitutivo dell’Organizzazione: al Paese inadempiente l’assistenza poteva essere sospesa o interrotta.
Ecco allora chiarito il motivo per cui è il Piano Marshall e non la dichiarazione di Schuman a segnare la genesi dell’Europa unita. Questa è invero il frutto di un mercato delle riforme: i momenti caratterizzanti il suo sviluppo sono occasioni per ottenere riforme in senso neoliberale come contropartita per forme di assistenza finanziaria. L’Europa unita è poi un progetto atlantista, è cioè tenuta insieme dalla volontà statunitense di usare il Vecchio continente nella sua lotta contro l’Unione sovietica prima e la Russia dopo, tanto che il venir meno di questa volontà sta accelerando la sua implosione.
L’allargamento a sud
Il primo momento caratterizzante lo sviluppo dell’Europa unita è il suo allargamento a sud. Ha interessato i Paesi liberatisi dalle dittature fasciste a metà anni Settanta, i quali chiesero subito di aderire all’allora Comunità economica europea: Grecia, Portogallo e Spagna.
Bruxelles non poteva rigettare la richiesta, ma neppure accettare che l’adesione avvenisse senza mettere in discussione quanto avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile all’affermazione del neoliberalismo. Il che, dal punto di vista formale, veniva espresso sotto forma di preoccupazione per le condizioni in cui versavano i Paesi candidati: afflitti da elevati livelli di disoccupazione, da una bilancia dei pagamenti in forte sofferenza e da scarsi livelli di industrializzazione.
A essere particolarmente sotto tiro fu il Portogallo, la cui Costituzione era nata in un clima ancora condizionato dagli accadimenti che portarono alla sconfitta della dittatura fascista. La Rivoluzione dei garofani ispirò invero un articolato in cui si menzionava la volontà del popolo di “aprire la strada a una società socialista”, ovvero di promuovere la trasformazione della Repubblica “in una società senza classi” nella quale “socializzare i mezzi di produzione”. E se anche il clima politico cambiò in fretta con la vittoria di forze conservatrici alle elezioni del 1971, ciò non mise in discussione scelte di politica economica sgradite al livello europeo: come il ricorso alla nazionalizzazione nell’industria e nei servizi. Il tutto mentre il Paese aveva un debito pubblico particolarmente elevato, dovuto tra l’altro dai costi collegati alla concessione dell’indipendenza alle colonie ancora sottomesse dal regime fascista.
A preparare il Portogallo per l’adesione ci pensò il Fondo monetario internazionale, che per l’occasione ricevette dalle autorità europee una sorta di mandato a farsi carico della questione. Di qui la concessione di due prestiti: il primo nel 1976, a un anno dalle prime elezioni libere vinte dai Socialisti di Mario Soares e in concomitanza con la richiesta di adesione alla costruzione europea, e il secondo tra il 1983 e il 1985, ovvero nel triennio immediatamente precedente l’ingresso nelle Comunità.
Soprattutto in questa seconda occasione le condizioni per l’assistenza finanziaria sono state particolarmente efficaci nell’orientare la politica economica del Paese. Non venne direttamente imposta la privatizzazione delle imprese in mano pubblica, ma questa fu di fatto avviata con una sostanziale riduzione delle sovvenzioni statali. Il Portogallo si impegnò a contenere la spesa attraverso “la revisione del sistema di prestazioni sociali”. Per contribuire al contenimento dell’inflazione, oltre che per alimentare politiche di sostegno all’offerta, si preannunciarono inoltre riforme in materia lavoristica finalizzate “a moderare il costo del lavoro” con il settore pubblico chiamato a “servire da esempio per la negoziazione salariale nel settore privato”. Stesso impegno per incrementare la precarietà nel lavoro, quale inevitabile conseguenza delle misure volte ad “aumentare la mobilità della manodopera” e la “flessibilità nell’utilizzo della manodopera”.
L’allargamento a est
Se l’allargamento a sud ha posto problemi all’agenda neoliberale europea, quello a est non è certo stato da meno. Diversamente dalle dittature fasciste, infatti, quelle socialiste non avevano rinnegato il liberalismo politico semplicemente per consentire una riforma di quello economico. Di qui la notevole mole di problemi, che le istituzioni europee decisero di affrontare ricorrendo ancora al mercato delle riforme.
Dell’ampliamento si iniziò a discutere a partire dal 1993, poco prima che i Paesi interessati avanzassero formale richiesta di adesione, per stabilire gli standard che i candidati avrebbero dovuto possedere per far parte dell’Unione. Fu soprattutto sullo sviluppo dell’economia di mercato che si volle concentrare l’attenzione: tra le misure da adottare in attesa della formale adesione figurano l’intensificazione delle relazioni commerciali tra l’Unione e i Paesi dell’est attraverso la progressiva costruzione di una zona di libero scambio nella quale “vietare le pratiche restrittive, l’abuso delle posizioni dominanti e gli aiuti pubblici che falsano o minacciano di falsare la concorrenza”. Nel frattempo si sarebbero sostenuti gli sforzi intrapresi dai Paesi dell’est per “modernizzare le loro economie indebolite da quarant’anni di pianificazione centrale”, ricorrendo all’aiuto finanziario della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
L’accordo costitutivo di quest’ultimo ente contiene indicazioni molto chiare circa i suoi compiti: la Banca deve promuovere l’economia di mercato, quindi “l’iniziativa privata”, lo “spirito imprenditoriale” e le “riforme strutturali” necessarie “allo smantellamento dei monopoli, al decentramento e alla privatizzazione”.
Il mercato delle riforme viene esplicitato nella precisazione per cui “le risorse e gli strumenti della Banca sono utilizzati esclusivamente per conseguire” le sue finalità istitutive. E se un Paese assistito “attua politiche incompatibili” si può “sospendere o modificare in altro modo l’accesso… alle risorse della Banca”. Il tutto mentre “il nesso tra aspetti politici ed economici” implica “un’attenzione primaria per i diritti civili”, sicché i diritti sociali “possono essere presi in considerazione”, non però “nella valutazione dei progressi” compiuti dal Paese assistito.
La crisi del debito
Il mercato delle riforme in area europea è stato poi alimentato in occasione della ristrutturazione dei debiti sovrani, cresciuti in modo esponenziale per effetto della crisi del 2008: crisi nata dalla sofferenza del settore creditizio provocata da un eccesso di indebitamento privato, poi divenuta crisi del debito sovrano per effetto della mole di denaro pubblico utilizzata per salvare le banche.
La materia era ed è complessa, dal momento che si ispira al principio del non salvataggio finanziario: l’Europa non può farsi carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali. L’assistenza finanziaria si può dunque ammettere esclusivamente se dettata da necessità di ordine superiore: per impedire che le conseguenze del dissesto finanziario di un singolo Paese ricadano sulla costruzione europea nel suo complesso.
Proprio questo principio ha ispirato una disposizione aggiunta al Trattato sul funzionamento dell’Unione (art. 136). Lì si è prevista l’istituzione del celeberrimo Meccanismo europeo di stabilità (Mes), autorizzato a concedere assistenza finanziaria solamente ove “soggetta a una rigorosa condizionalità”. Parliamo ovviamente di condizionalità volte a imporre l’ortodossia neoliberale: l’assistenza finanziaria è concepita come contropartita di misure volte a diminuire le uscite: a contenere la spesa pensionistica e sociale, inclusa ovviamente quella per la sanità e l’istruzione, a congelare o ridurre le retribuzioni dei pubblici dipendenti, e in genere a ridimensionare la Pubblica amministrazione. A queste misure si aggiungono poi indicazioni sulle modalità di incremento delle entrate: programmi di privatizzazioni e liberalizzazioni, in particolare nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni e dei servizi pubblici locali.
Vi sono poi condizionalità concernenti la riforma del mercato del lavoro, concepita in modo tale da ripristinare più elevati livelli di libertà contrattuale, utili fra l’altro a rimuovere gli ostacoli alla flessibilizzazione e precarizzazione della relazione di lavoro: ad assimilarla sempre più a una relazione di mercato qualsiasi. Il tutto mentre si incentiva lo sviluppo di relazioni industriali in cui sia limitato il potere dei sindacati dei lavoratori: ad esempio promuovendo la possibilità per gli accordi a livello di singola impresa, dove più forte è il potere contrattuale del datore di lavoro, di derogare agli accordi conclusi a livello centrale, dove è più facile contrastare quel potere. Da notare infine il favore con cui si guarda all’introduzione di una componente del salario agganciata agli utili d’impresa, incentivata in quanto misura capace di indurre cooperazione tra capitale e lavoro.
La crisi pandemica
Secondo molti la crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria in corso ha indotto l’Europa unita a cambiare rotta rispetto a quanto finora realizzato. Le misure adottate smentiscono però questa previsione, mettendo in luce come anche questa crisi, come quella del debito sovrano, sia stata invece l’occasione di ribadire e se possibile rafforzare l’ispirazione neoliberale della costruzione europea. Il tutto ricorrendo ancora al mercato delle riforme come espediente attraverso cui presidiarne l’essenza di dispositivo neoliberale.
Lo ricaviamo in particolare dalla disciplina relativa al Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and resilience facility), un fondo per l’erogazione di prestiti e sovvenzione nell’ambito del quadro finanziario per gli anni dal 2021 al 2027. Le condizionalità collegate a questa forma di assistenza sono molteplici, e tra queste le più insidiose sono quelle contenute nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr): i piani contenenti l’elencazione dettagliata degli investimenti che gli Stati beneficiari dell’assistenza si impegnano a realizzare, unitamente alle riforme cui essa viene condizionata (Regolamento 12 febbraio 2021 n. 241).
Significativo quanto contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, del quale si possono evidenziare a titolo esemplificativo due riforme subito realizzate al fine di promuovere la semplificazione in materia di contratti pubblici e in materia ambientale, e più precisamente per snellire le verifiche antimafia e la valutazione di impatto ambientale (decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77). In entrambi i casi si è inteso onorare una massima in linea con l’ispirazione neoliberale della costruzione europea: la massima secondo cui l’intervento pubblico che non si traduce in un mero sostegno al funzionamento del mercato produce “la moltiplicazione dei fenomeni corruttivi”.
Da notare anche l’impegno ad attuare un provvedimento che aveva affidato all’esecutivo il compito di predisporre “leggi annuali per il mercato e la concorrenza”, al fine di “rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all’apertura dei mercati” e “promuovere lo sviluppo della concorrenza” (art. 47 legge 23 luglio 2009 n. 99). Il provvedimento è stato ampiamente disatteso e in effetti si era proceduto in questo senso solo una volta (legge 4 agosto 2017 n. 124). Le condizionalità macroeconomiche collegate al Piano nazionale hanno radicalmente inciso su questa situazione: sono state emanate le leggi annuali per il 2021 (legge 5 agosto 2022 n. 118), il 2022 (legge 30 dicembre 2023 n. 214) e il 2023 (legge 16 dicembre 2024 n. 193).
Il federalismo hayekiano
L’Europa unita non è dunque cambiata. Al contrario si è consolidata nella sua essenza di dispositivo neoliberale e il suo assetto non costituisce un riscontro della sua incompletezza, bensì della sua capacità di assicurare il risultato per cui è stata concepita.
In particolare è fuorviante pensare che la coesistenza di una politica monetaria comune e di una politica fiscale e di bilancio formalmente radicata a livello nazionale sia transitoria: che la seconda sia destinata a seguire le orme della prima. Giacché questa situazione ricalca lo schema prefigurato sul finire degli anni Trenta da un padre del neoliberalismo che aveva visto nel federalismo un fondamentale catalizzatore di riforme in senso neoliberale.
Il riferimento è a Friedrich von Hayek, e in particolare a un suo scritto nel quale sollecita la formazione di una federazione tra Stati cui attribuire il compito di eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei fattori produttivi, e ottenere così la moderazione fiscale: una pressione elevata “spingerebbe il capitale e il lavoro da qualche altra parte”. La libera circolazione consentiva insomma di spoliticizzare l’ordine economico, dal momento che sottraeva alle “organizzazioni nazionali, siano esse sindacati, cartelli od organizzazioni professionali”, il “potere di controllare l’offerta di loro servizi e beni”. Se infatti lo Stato nazionale alimentava una “solidarietà d’interessi tra tutti i suoi abitanti”, la federazione impediva legami di “simpatia nei confronti del vicino”, tanto che diventavano impraticabili “persino le misure legislative come le limitazioni delle ore di lavoro o il sussidio obbligatorio di disoccupazione”.
Altrimenti detto, von Hayek evidenzia come la dimensione nazionale sia alla base del conflitto redistributivo, e come questo possa essere neutralizzato solo edificando un ordine economico nel quale i prezzi si formano per il solo effetto del libero incontro di domanda e offerta: un ordine nel quale “le varie comunità d’interesse si sovrappongano territorialmente e non si identifichino mai a lungo con gli abitanti di una particolare regione”. Proprio quanto avviene nel contesto europeo, ridotto a ordine economico entro cui i prezzi costituiscono il risultato del funzionamento del principio di concorrenza, in quanto tale impermeabile a qualsiasi intervento capace di mettere a rischio la riduzione dell’inclusine sociale e inclusione nel mercato. Il tutto presidiato da un ordine politico a cui si cede sovranità nella misura necessaria e sufficiente a desocializzare il mercato, quindi privo di meccanismi destinati a consentire la partecipazione democratica.
Insomma, la mancanza di un demos europeo, ovvero di una comunità politica entro cui realizzare forme di redistribuzione della ricchezza dalle persone e dai territori svantaggiati alle persone e ai territori fortunati, costituisce l’ostacolo insormontabile alla costruzione di una Europa sociale. E fa apparire i suoi fautori come i custodi di un sovranazionalismo speculare rispetto al nazionalismo di coloro i quali agitano identità violente ed escludenti quali valori premoderni volti a sostenere la modernità capitalista. Custodi incapaci di riconoscere come la rivendicazione della dimensione nazionale possa essere invece affermata come forma di ripoliticizzazione del mercato: come ripristino della cinghia di trasmissione tra il conflitto sociale e la disciplina dell’ordine economico.
L’Europa atlantista
Si è detto del Piano Marshall quale atto fondativo dell’Europa unita e della sua conseguente ispirazione atlantista. Dobbiamo ora dire di come essa si sia sviluppata nel corso degli anni, sino a divenire la causa almeno indiretta della sua attuale involuzione bellicista e con ciò del suo definitivo fallimento.
L’atlantismo ha rappresentato il collante dell’unità europea negli anni della Guerra fredda, quando Bruxelles è servita per impedire scelte politiche nazionali incompatibili con l’adesione al credo neoliberale. Anche e soprattutto quando quelle scelte si fondavano su valori costituzionali, che occorreva scardinare a qualsiasi costo: la prevalenza del diritto europeo sul diritto interno è servita per disinnescare le Carte fondamentali dei Paesi che erano usciti dal fascismo ripristinando la democrazia politica e affiancandole la democrazia economica. Paesi poi identificati come Pigs e divenuti il bersaglio preferito del mercato delle riforme utilizzato per far fronte alla crisi del debito.
Sempre l’atlantismo ha poi ispirato lo sviluppo della costruzione europea dopo la dissoluzione del blocco sovietico, non a caso seguita dall’allargamento della Nato di concerto con quello dell’Unione: a sottolineare la dipendenza dell’agenda di Bruxelles da quella di Washington. Nel 2004 aderiscono infatti all’Europa unita l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l’Ungheria, mentre tre anni dopo è il turno della Bulgaria e della Romania.
Alla luce di tutto questo occorre valutare il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ufficialmente e solennemente avviato dalla Presidente della Commissione europea in occasione del suo viaggio a Kiev a qualche settimana dallo scoppio della guerra, a cui ha fatto seguito il formale riconoscimento all’Ucraina dello status di candidato. Non è certo la prima volta che l’Ucraina chiede di far parte dell’Unione, ma finora si era sempre risposto che l’eventuale conclusione positiva dell’iter di adesione avrebbe richiesto decenni. Ora si ipotizzano tempi compressi, ma soprattutto non si mettono in discussione i problemi che questo comporta: per aderire occorre soddisfare i cosiddetti criteri di Copenaghen, ovvero i criteri di adesione decisi in occasione del Consiglio europeo tenutosi nel 1993 nella capitale danese. E questi rinviano a caratteristiche dell’ordine politico ed economico che l’Ucraina è ben lontana dal possedere a prescindere dalla drammatica situazione che sta vivendo.
Soprattutto conosciamo i danni all’economia nazionale e alla tenuta democratica prodotti dall’adesione all’Unione europea di molti tra i suoi Paesi membri. La Grecia era molto più europea dell’Ucraina, ma questo non ha impedito a Bruxelles di sanzionare le sue resistenze all’ordine capitalista con la macelleria sociale. Qualcuno pensa davvero che per Kiev l’adesione possa invece tradursi in un beneficio: che la miseria politica ed economica a cui sono condannati Paesi ben più robusti sia risparmiata per motivi umanitari a un Paese fragile e instabile da tutti i punti di vista?
Trump e il futuro dell’Unione europea
Se così stanno le cose, l’unico beneficio riconducibile all’adesione dell’Ucraina all’Europa unita riguarderà gli Stati Uniti. Sotto la presidenza Biden essa era considerata un sostituto dell’adesione alla Nato, in una situazione nella quale era manifesta l’intenzione di utilizzare il conflitto tra Ucraina e Russia come occasione per ottenere comunque una espansione dell’Alleanza atlantica nel Vecchio continente.
Il tutto accompagnato da iniziative spregiudicate volte a punire gli Alleati in odore di vicinanza con Mosca. Esemplare da un simile punto di vista la distruzione di Nord Stream 2, il gasdotto realizzato per trasportare il gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale e consolidare un fondamento della crescita economica tedesca: l’utilizzo da parte dell’apparato produttivo tedesco di energia a buon mercato. Distruzione che è più che plausibile attribuire agli Stati Uniti, che ben può essere annoverata tra le cause dall’attuale crisi politica ed economica tedesca e che ciò nonostante è stata subita con sorprendente rassegnazione da parte di Berlino.
Da un simile punto di vista la presidenza Trump non indica un sostanziale cambiamento nella strategia di Washington. Certo, ora il Vecchio continente non è più considerato utile per le finalità di politica estera degli Stati Uniti, ma prima era ritenuto uno strumento: un’area geopolitica da sottomettere ai propri interessi e non certo un alleato da trattare alla pari.
Di più. L’attuale disinteresse degli Stati Uniti ha prodotto una deriva bellicista dell’Europa manifestatasi con una tempistica e una virulenza impensabili sino a ieri. La sua essenza atlantista ha ora ispirato iniziative come la scelta di accantonare l’austerità neoliberale per consentire l’esplosione della spesa militare, ovvero per provocare una ulteriore contrazione della spesa sociale da tagliare nel nome di un conflitto militare il cui risultato appare scontato: non rovescerà i rapporti di forze tra la Russia e l’Europa unita ma se non altro evidenzierà ancora una volta la sua essenza neoliberale. E chiarirà come questa concerne il sacrificio della partecipazione democratica e della giustizia sociale, a riprova del suo successo in quanto dispositivo neoliberale irriformabile. Vi sono dichiarazioni esplicite in questo senso: l’Europa è pronta a mobilitare 800 miliardi di Euro nell’ambito di un programma denominato ReArm Europe, destinato ad incrementare il debito degli Stai membri e soprattutto a farlo senza intaccare i parametri di Maastricht. È insomma un’Europa nata prima come mercato senza Stato, cresciuta come moneta senza Stato e pronta a divenire un esercito senza Stato: e proprio per questo a rimanere una entità politica senza democrazia.
*Alessandro Somma è Professore di Diritto comparato nella Sapienza Università di Roma. È saggista e giornalista pubblicista, Direttore de “La fionda”.