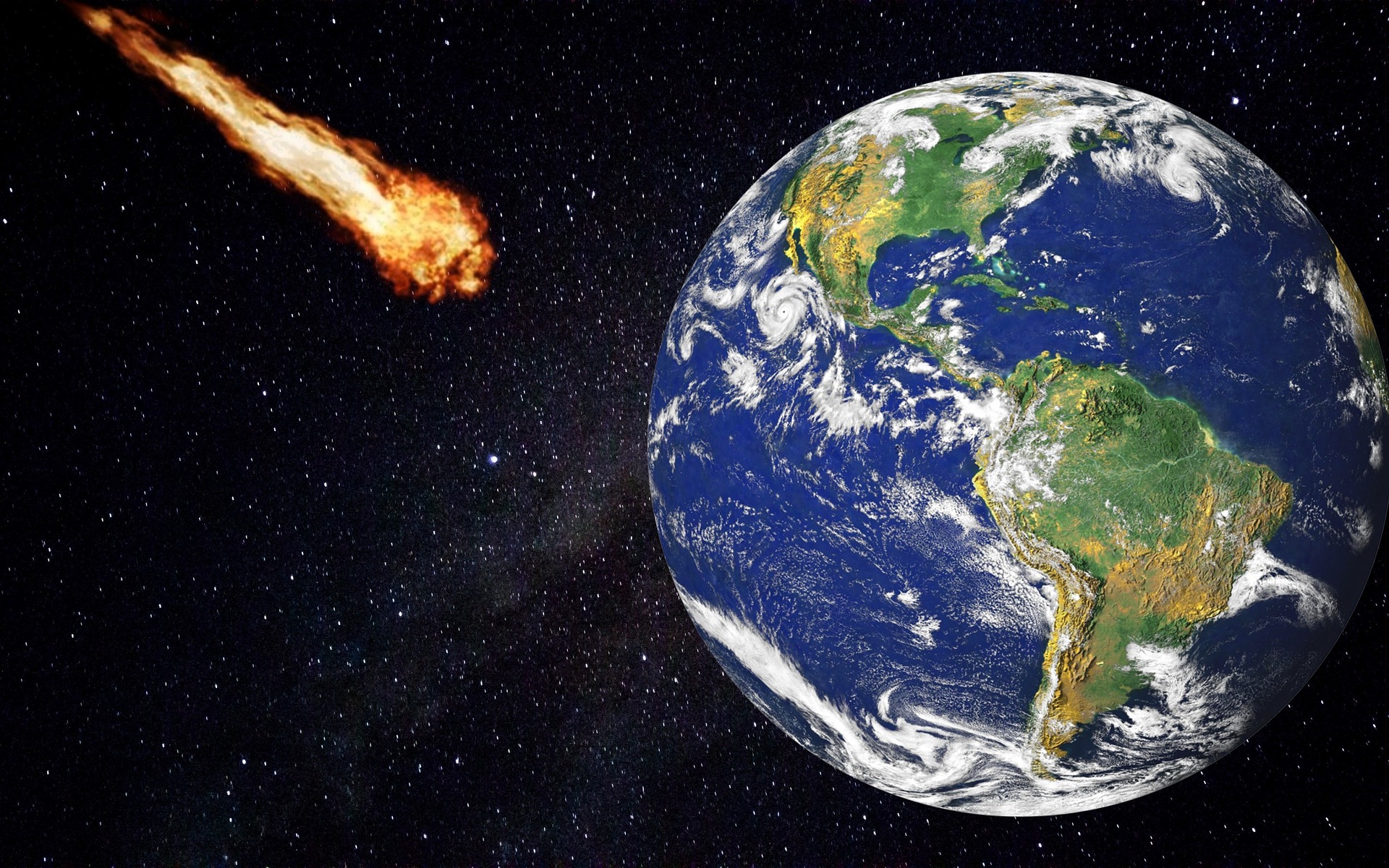Editoriale – Per un eco-socialismo autogestionario fondato sulla riproduzione
Paolo Ferrero
Il cambio climatico e la sindemia del COVID sono due facce della stessa medaglia.
Ci parlano dell’aspetto distruttivo che ha assunto lo sviluppo capitalistico e delle forme in cui si manifesta questa distruzione: non vi sarà una “ora X”, un istante in cui si verificherà la scomparsa della specie umana sulla terra. Noi non faremo la fine dei dinosauri dopo l’impatto devastante di un asteroide. Al contrario, noi vivremo un’agonia progressiva, un peggioramento delle condizioni di abitabilità del pianeta che determinerà scarsità di acqua potabile, uragani, siccità, inondazioni, migrazioni, razzismo, guerre, ulteriori pandemie.
In altri termini, non è della morte ma dell’esponenziale degrado della vita e dei rapporti sociali che dobbiamo avere paura. Il cambio climatico non è un problema settoriale, che riguarda l’ambiente, ma è destinato a determinare l’implosione della civiltà umana. Una catastrofe che il consumismo dei ricchi accentua pesantemente e che colpisce più duramente i soggetti fragili e deboli, a partire dai popoli e dai paesi delle periferie, dalle classi subalterne in generale, dai migranti, dalle donne.
La green economy è inefficace
Come hanno capito benissimo i ragazzi e le ragazze di Friday For Future e del movimento contro il cambio climatico, questa situazione chiede una risposta rapida e radicale. Le classi dirigenti, che pure si sono rese conto del problema lo affrontano cercando di rendere profittabili le produzioni compatibili con l’ambiente e di spingere fuori mercato le produzioni inquinanti.
Anche se fosse praticata con un rigore ben maggiore di quello attuale, questa green economy capitalistica è destinata ad avere tempi troppo lunghi per evitare la catastrofe. Si fonda sullo stesso paradigma che ci ha portato al disastro. Da un lato vogliono ridurre a merce tutta la natura, dargli un prezzo e – per questa via – difenderla. Non ridete. È la giustificazione che viene portata alla decisione di quotare in borsa l’Acqua potabile da parte di Black Rock, la più grande società di investimenti del mondo. Nello stessa direzione, la Borsa di New York ha deciso di aprire una nuova classe di attivi finanziari, gestiti da una nuova categoria di imprese, le “Natural Assets Companies” (NAC): così quoteremo in borsa l’intero pianeta. È la logica di “dare un prezzo” alla natura in modo che entri nei meccanismi di calcolo economico e per questa via – dicono “lor signori” – venga tutelata.
Dall’altro lato – ma non è diversa la logica – vi è la strada che indica Draghi (e Lagarde) che dice:
“Il settore pubblico dovrà farsi carico di aiutare in particolare i cittadini più deboli ma anche di guidare nei suoi aspetti fondamentali questa transizione (ambientale, ndr). Deve anche assicurarsi che i tempi della transizione siano rapidi, ma compatibili con la capacità di conversione delle aziende”.
Al di la delle chiacchiere di propaganda, in entrambe queste proposte la riconversione ambientale e la lotta al cambio climatico restano sullo sfondo. Nel primo caso, diventano un fattore di costo di cui tenere conto; nel secondo caso, la mano pubblica deve puntare a tempi rapidi “ma compatibili con la capacità di conversione delle aziende”.
Questa strada non sostituisce al profitto un’altra logica: limitandosi a incorporare nella logica del profitto l’attenzione all’ambiente, è del tutto inefficace, è tragicamente troppo lenta. Del resto, al di là delle chiacchiere, il loro obiettivo non è impedire il cambio climatico ma costruire una nuova fase di accumulazione capitalistica fondata sulla green economy, in cui una maggiore attenzione all’ambiente si accompagni all’ulteriore distruzione dei diritti sociali e del lavoro. È infatti evidente che, nei disegni di Draghi e soci, tanto la riconversione ambientale quanto l’industria 4.0 prevedono un’ulteriore riduzione dei diritti e del potere della classe lavoratrice.
Al contrario il nostro obiettivo è la rapida riconversione ambientale, guidata dal pubblico, fondata sulla partecipazione attiva dei lavoratori e intrecciata con una drastica riduzione dell’orario di lavoro. Come ha capito il movimento lanciato da Greta, un’economia fondata sul profitto e sullo sfruttamento è incompatibile con il mantenimento di un equilibrio ambientale sul pianeta terra.
Pianificare democraticamente la riconversione ambientale
Il mancato re Carlo d’Inghilterra, nella COP 26 di Glasgow, ha detto che è necessario affrontare l’emergenza ambientale “come una guerra”, con “una campagna in stile militare per dispiegare la forza delle migliaia di miliardi” necessari a sostenere la transizione verso “un’economia più sostenibile”. Ad oltre due secoli dalla Rivoluzione Francese, evidentemente i nobili ridotti a tappezzeria hanno una capacità di comprensione del reale maggiore della borghesia, perché l’evocazione della guerra – ognuno ha gli ideali che si merita – segnala proprio la necessità di “cambiare logica”.
Noi del “terzo stato” siamo in grado di esprimerlo meglio: si tratta di progettare un deciso intervento pubblico finalizzato alla rapida modifica del modo attraverso cui vengono soddisfatti i bisogni sociali. Quando proponiamo il “green New Deal”, parliamo di questo.
Gli obiettivi del piano debbono essere decisi democraticamente, attraverso una ampia discussione; le forme di realizzazione e implementazione del piano debbano essere decentrate, autogestite e controllate dal basso. Alla dialettica stato/mercato occorre sostituire una dialettica stato/autogestione sociale. In questo quadro, decisivo è il controllo operaio, e cioè il coinvolgimento di chi lavora attorno ai nodi del “cosa produrre, come, per chi, dove”.
Il superamento della logica del mercato deve fondarsi sul superamento della funzione subordinata del lavoro, e un rapido progetto di riconversione produttiva non può che essere guidato da chi lavora in un contesto in cui venga garantita la piena occupazione.
Si tratta quindi di aprire una fase di transizione, in cui mercato e profitto non costituiscano più il principio a cui si deve piegare la riproduzione sociale. Questa transizione non è, quindi, un optional o una opinione politica tra le altre. È la necessità dell’umanità qui e ora. Non è un caso che lo diciamo noi e il Papa: solo chi ha un punto di vista autonomo dall’accumulazione del capitale può riconoscere nel profitto la causa del disastro.
Garantire diritti, non merci
L’intervento pubblico finalizzato alla riconversione ambientale e all’allargamento dei diritti sociali non può però concretizzarsi solo nella produzione di merci meno inquinanti. Superare la logica del profitto significa soddisfare i bisogni umani in una forma diversa da quella delle merci e del consumismo.
Si tratta cioè di riprogettare complessivamente il modo in cui vengono affrontate le necessità delle persone, mettendo al centro i valori d’uso e non i valori di scambio. Proviamo, con due esempi, a vedere cosa significa concretamente.
Il primo esempio, riguarda la sanità, e lo avevo già sviluppato nell’editoriale del numero 6 della rivista, quello dedicato al Pubblico.
Molte persone pensano che sanità pubblica e sanità privata siano solo due modi diversi di perseguire il medesimo obiettivo. Non è così. La sanità pubblica è fondata sul principio che prevenire è meglio che curare, che la cura è l’extrema ratio. La sanità pubblica è quindi fondata sulla prevenzione, sull’educazione, sulla ricerca dei fattori di rischio al fine di rimuoverli.
Al contrario, la sanità privata è finalizzata alla produzione di prestazioni sanitarie: più ne vengono fatte e più la struttura sanitaria privata guadagna. Con ogni evidenza per la sanità privata la prevenzione è una iattura: se le malattie diminuiscono, si riduce il “mercato potenziale” e con esso i profitti. Risulta quindi evidente che sanità pubblica e sanità privata, al di là delle apparenze, non hanno lo stesso obiettivo.
Per la sanità pubblica l’obiettivo fondamentale è lo stato di salute delle persone – fondato sulla prevenzione degli stati di disagio – e le prestazioni sanitarie sono solo uno dei modi di intervento e debbono essere limitate al massimo. Per la sanità privata invece, l’obiettivo è il maggior guadagno possibile da ogni stato di malessere e quindi la realizzazione del maggior numero possibile di prestazioni sanitarie. Per chi gestisce la sanità privata il problema fondamentale è quello di poter vendere merci – le prestazioni sanitarie – e la guarigione non è che l’effetto che motiva l’acquisto.
Il mettere al centro la soddisfazione dei bisogni, e non la vendita di merci, può e deve essere fatto in tutti i campi fondamentali. Pensiamo alla mobilità. Oggi questa avviene in larga parte in forme private, e solo una parte del “trasporto collettivo” viene gestita pubblicamente (e malamente, se guardiamo ai treni pendolari ed al trasporto pubblico locale). La mobilità è centrata sull’utilizzo dell’automobile privata che è stata la spina dorsale dello sviluppo capitalistico nel XX secolo.
Oggi la risposta capitalistica al cambio climatico è finalizzata in primo luogo alla sostituzione di automobili a combustione interna con automobili elettriche: resta intatto il dogma dell’auto privata che deve essere comprata (o al massimo affittata). Che nelle città la velocità commerciale della automobili sia oramai ridicolmente bassa, che sia folle muovere una tonnellata di ferraglia e plastica per spostare una o due persone, che la maggior parte delle automobili resti inutilizzata per larga parte del tempo, non entra nemmeno nell’orizzonte visivo dei capitalisti: il loro problema è continuare a vendere automobili, continuare a vendere merci e fare profitti, non ripensare il modo in cui la gente può spostarsi. Anzi, per garantirsi il consenso spendono un mucchio di denaro in pubblicità (attorno al 3% del costo complessivo di una automobile).
Per non parlare del fatto che l’immaginario prodotto attraverso la pubblicità tende a far coincidere l’identità maschile con il possesso dell’automobile potente e veloce, cioè con un comportamento sociale idiota e distruttivo. Siamo di fronte non solo alla devastazione dell’ambiente, ma anche a quella dei cervelli.
Al contrario, il nostro obiettivo è di soddisfare il bisogno di mobilità, garantire il diritto alla mobilità puntando alla riduzione drastica del consumo energetico e delle emissioni. Questo significa riprogettare completamente gli spostamenti, dall’uso del monopattino, alla bicicletta, al motorino, all’automobile, al minibus, all’autobus, al treno, all’aereo, il tutto in un quadro pubblico. L’auto privata come spina dorsale della mobilità degli umani deve essere rapidamente superata: non perché si debba usare solo l’autobus o i trasporti collettivi, ma perché il diritto alla mobilità come diritto individuale, può essere positivamente soddisfatto in forme diverse e migliori di quelle fondate sulla proprietà privata di una tonnellata di ferraglia.
Si tratta di progettare una gestione pubblica della mobilità e cioè di programmare in forme semplici e flessibili l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto – sia quelli ad utilizzo individuale che quelli ad utilizzo collettivo – garantendo la mobilità e riducendo l’impatto ambientale. La mobilità deve diventare un diritto.
Non tornare indietro ma cambiare strada: demercificare
L’intervento pubblico che proponiamo non si riduce quindi alla modifica dei rapporti proprietari, ma introduce una modifica dei rapporti sociali. Non si tratta di produrre le stesse merci dei privati con una diversa etichetta, ma di soddisfare i bisogni sociali nella forma del diritto (alla mobilità, alla salute, all’abitare, allo studio….) senza passare attraverso la forma della merce. Al contrario di cosa hanno fatto in questi 40 anni di privatizzazioni, trasformando le persone in “clienti”, occorre invece trasformare i sudditi in cittadini. Occorre demercificare le relazioni sociali a partire dalla riduzione drastica dell’orario di lavoro, perché l’acquisto di beni e servizi in forma privata – su cui è fondata la logica del profitto e quindi il capitalismo – è incompatibile con la vita dell’umanità sulla terra. Mentre i capitalisti vogliono trasformare tutto in merci – acqua e aria compresa – noi vogliamo rispettare l’ambiente, soddisfare bisogni e garantire i diritti e per far questo è necessario uscire dalla logica del profitto.
Una riconversione ambientale efficace e rapida non è quindi fondata solo sulla “riduzione”, sulla riduzione del consumismo: si tratta di cambiare logica, di soddisfare i bisogni in modo diverso, di demercificare. Non amo la parola “decrescita”, perché dà l’idea che si debba innestare la retromarcia. Non è così: la crescita infinita è l’effetto dell’accumulazione infinita del capitale. Per uscire da questo delirio occorre superare le cause, non solo aggredire gli effetti. Per questo, occorre demercificare – il lavoro e la natura in primo luogo – aprendo così la strada a un rapporto equilibrato con la natura e alla liberazione degli umani. Al posto dell’accumulazione del capitale e quindi della produzione infinita di merci, si tratta di porre al centro il tema della riproduzione sociale e naturale. Allo stesso modo, occorre demercificare e socializzare la conoscenza e la scienza. Oggi il capitale domina il creato attraverso l’appropriazione privata dei frutti della ricerca scientifica, e trasforma la natura stessa in merce manipolabile e in occasione di profitto. Sul monopolio dei frutti della scienza si fonda la produzione di ricchezza, il potere e per certi versi il prestigio, l’egemonia del capitale. La socializzazione della scienza – e quindi del potere che ne deriva – è uno snodo fondamentale per affrontare in forme razionali i problemi dell’umanità e poterli risolvere superando ogni complottismo.
La proposta eco-socialista non ha nulla a che vedere con una rigida pianificazione burocratica. Demercificare significa agire una programmazione pubblica democratica e fondata sull’autogestione e il controllo sociale. Vogliamo costruire un movimento di massa che rivendichi la soddisfazione dei bisogni fondamentali come diritto pubblico garantito ad ogni individuo, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.
Antropocene o capitalocene?
Il capitalismo ha avuto il merito storico di aver applicato la scienza ai processi produttivi, dando un grande impulso allo sviluppo tecnologico e all’aumento della produttività del lavoro. Questo sviluppo ha prodotto enormi sofferenze sociali, ma anche un contraddittorio miglioramento complessivo delle condizioni di vita degli umani. Questo dato ha caratterizzato gli ultimi tre secoli di vita dell’umanità, in cui il capitalismo e il movimento operaio si sono scontrati e confrontati. Col procedere del tempo l’elemento contraddittorio si è accentuato ed il sistema produttivo è diventato palesemente incompatibile con l’equilibrio ambientale del pianeta. La “distruzione creativa” di cui ci parlava Schumpeter glorificando la funzione del capitalismo imprenditoriale, è diventata sempre più “creazione della distruzione”, propria di un sistema che distrugge la natura, brevetta e privatizza il vivente, induce pandemie sempre più frequenti, produce diseguaglianze sempre più macroscopiche ed inaccettabili. La stessa ricerca spasmodica dell’aumento del PIL che guida le classi dominanti, è destinata ad aggravare i problemi ed è in definitiva incompatibile con la vita umana sul pianeta.
Come abbiamo sottolineato, occorre cambiare direzione; va anche detto con nettezza che l’origine del disastro ambientale non è l’umanità in quanto tale, ma proprio il capitalismo e la sua logica di funzionamento. Nel dibattito pubblico degli ultimi decenni ha preso piede la nozione di “antropocene”, connotando con questa parola la nuova era geologica in cui stiamo vivendo, caratterizzata dalle modifiche all’equilibrio naturale indotte dall’azione dell’umanità negli ultimi secoli.
Questa periodizzazione fotografa un elemento vero, ma è fuorviante: invece che di “antropocene” dobbiamo parlare di “capitalocene”. L’impatto devastante dell’umanità sulla vita del pianeta è il frutto diretto e avvelenato del capitalismo che ha ridotto il lavoro e la natura a merce. Non gli umani, non la crescita della popolazione ma la logica del profitto e la crescita smisurata della produzione di merci sono alla base della distruzione del pianeta. Ribadisco che l’origine del disastro non sta nell’umanità in quanto tale ma nella forma capitalistica di organizzazione dei rapporti sociali, fondata sull’accrescimento infinito dell’accumulazione del capitale.
Superare capitalismo e delirio di onnipotenza maschile
In questo editoriale ho cercato di mostrare la necessità dell’urgenza della riconversione ambientale e sottolineato la lentezza e l’inefficacia della green economy. Ho poi motivato la necessità di superare la logica del profitto e della mercificazione, intrecciando difesa della natura, diritti sociali, riduzione dell’orario di lavoro. Da ultimo, ho evidenziato come oggi il capitalismo sia il motore della barbarie incombente sociale e ambientale, e che sia quindi necessario superarlo in direzione eco-socialista, con un piano pubblico, democratico, autogestionario e fondato sul controllo sociale. Ho cercato cioè di mostrare perché il comunismo è una necessità per l’umanità.
Potrei chiudere qui, ma sarei reticente su un punto decisivo.
Negli ultimi 150 anni, ll progressismo che ha permeato il pensiero occidentale – anche quello del movimento operaio – ha teso a legare lo sviluppo della scienza e della tecnica a una sorta di delirio di onnipotenza: attraverso la scienza e la tecnica siamo in grado di dominare la natura e plasmare il futuro. Il dio delle grandi narrazioni religiose è stato sostituito dall’onnipotenza degli uomini – uso questo termine a ragion veduta – nel perseguire il progresso. Questa grande narrazione metafisica, fondata sullo sviluppo della scienza e della tecnica, è stata la manifestazione di un delirio di onnipotenza che ha contaminato tutte le correnti di pensiero, da chi propugnava il libero mercato a chi sosteneva i piani quinquennali.
La mia opinione è che il disastro ambientale e la vicenda paradigmatica del COVID ci obbligano ad una rottura con questa impostazione positivista e progressista. L’intervento umano, nell’epoca moderna, ha avuto le caratteristiche dell’apprendista stregone ed il capitalismo-fondato sull’espansione infinita dell’accumulazione di capitale – ha determinato conseguenze drammatiche.
Si tratta in altri termini di fare i conti con i nostri limiti, con la nostra non onnipotenza o – se volete – con la nostra “finitezza”.
Questo è un punto fondamentale: la proposta eco-socialista si deve accompagnare a una concezione antropologica fondata sul senso del limite. In questo quadro il tema che ci pone il movimento delle donne – la centralità della riproduzione al posto della centralità della produzione – mi pare ci indichi la strada giusta.
Per un’eco-socialismo fondato sulla riproduzione
La riproduzione non è l’eterno ritorno dell’identico: non è la ciclicità propugnata dai reazionari. La riproduzione è la possibilità del cambiamento e dell’innovazione evitando che queste divengano distruttive. La riproduzione è la verasfida che unisce cambiamento del soggetto, trasformazione sociale e riproduzione delle condizioni che rendono possibile l’esistenza
dell’umanità. Vale in termini individuali come in termini collettivi. Anche il soddisfacimento dei bisogni sociali nei paesi del sud del mondo deve essere ripensato in termini “riproduttivi” evitando di ripercorrere tutte le tappe distruttive dello sviluppo capitalistico.
La prospettiva della riproduzione aiuta anche a porre con i piedi per terra il tema della libertà dell’individuo. Oggi i liberisti propugnano la libertà come irresponsabile: un vero delirio di onnipotenza individuale. Non basta scandalizzarsi. Occorre indicare un’altra strada che contemperi libertà, individualità e responsabilità sociale. In altri termini, si tratta di costruire una nuova libertà fondata sulla consapevolezza dell’interdipendenza con gli altri umani e con la natura. Sappiamo che questa coscienza “di specie”, questo nuovo umanesimo può essere prodotto solo nel protagonismo popolare e nella socializzazione della conoscenza.
Il contrario di cosa accade oggi. A chi esalta l’individualismo più sfrenato rispondiamo che difficilmente ridiamo da soli: gli umani ridono in compagnia e provano gusto a far ridere gli altri. Gli uomini e le donne non sono atomi sociali incomunicanti, non sono monadi: sono esseri sociali.
Le relazioni comunitarie e sociali liberate dallo sfruttamento non sono una costrizione, ma uno spazio di libertà in cui gli individui possono crescere superando l’angoscia di essere soli. Riscoprire il nostro essere animali sociali e costruire una nuova umanità: anche di questo dobbiamo parlare quando vogliamo combattere il cambio climatico.
Immagine ripresa da pixabay.com